La mia stagione eurovisiva numero DICIOTTO – la settima da accreditato stampa on location – si è conclusa ormai più di tre settimane fa con la vittoria dell’Austria e di JJ (Johannes Pietsch) con il brano Wasted Love, scritto e composto dallo stesso artista assieme a Teodora “Teya” Špirić e Thomas Thurner.
Penso sempre che il momento giusto per tirare le fila di un grande evento come l’ESC non sia “a caldissimo”, ma quando si ha avuto pienamente il tempo di digerirlo e farsi un’idea a mente più possibile fredda (e non dettata dalla foga e dalle emozioni del momento, come succede sempre più spesso) di ciò che abbiamo vissuto.
Per quanto nel mondo reale le analisi siano già state fatte, il tutto sia stato già abbondantemente archiviato e impacchettato per l’anno prossimo, e magari i miei stessi venticinque lettori si saranno pure stufati di aspettarmi come Godot – credo che ci sia ancora un minimo di spazio per potere tornare con la mente ai giorni di Basilea. E quindi, come tradizione impone: quello che segue è il mio post-mortem dell’Eurovision Song Contest 2025.
L’ESPERIENZA EUROVISIVA
Basilea ha salutato il mio arrivo nel primo pomeriggio di sabato 10 maggio – dopo sei ore di viaggio in treno – e da subito si è rivelata come una città a misura di Eurovision, con un’atmosfera completamente diversa rispetto a quella vissuta un anno fa a Malmö.
Gli ottimi collegamenti dei mezzi pubblici – tram e autobus – hanno reso molto semplice raggiungere i tre punti cardine della settimana basilese: il centro città (che ospitava la Eurovision Square in Barfüsserplatz e la Eurovision Street allestita per l’occasione nella prospiciente Steinenvorstadt), il padiglione fieristico MesseBasel (sede dell’EuroVillage, dell’EuroClub e punto d’arrivo del Turquoise Carpet di domenica) e ovviamente la St. Jakobshalle Arena, situata nella zona ovest della città. Soggiornare nei pressi della stazione alla stazione – in ossequio alla regola aurea del “più vicino sei, meglio è” – si è rivelata una scelta azzeccata, ma non hanno sofferto troppo neppure i tanti accreditati e spettatori che hanno scelto di pernottare al di là del confine, con tempi di percorrenza verso l’arena che si aggiravano intorno alla mezz’ora.
Dopo la prima sosta in zona arena per ritirare l’accredito (e all’attiguo centro commerciale per l’acquisto di un adattatore costato ben 30 svanziche) il primo appuntamento è stato quello del Turquoise Carpet, svoltosi domenica pomeriggio nella cornice di una giornata a dir poco meravigliosa. La tradizionale passerella ha debuttato in una formula nuova e, a mio parere, riuscitissima: le delegazioni hanno attraversato due chilometri di città, dal municipio in Marktplatz fino al complesso fieristico della Messe Basel, viaggiando su tram d’epoca tra due ali di folla in festa. Una volta giunti all’EuroVillage, si sono concessi al pubblico sul palco (tra mini-interviste gestite – con risultati discutibili – dalla drag queen Odette Hella’Grand, che ha raccolto il testimone dalle mani di Elecktra e Tia Kofi viste l’anno passato) e poi alle domande della stampa.
L’evento si è svolto in un clima festoso e celebrativo, ma che comunque ha lasciato spazio alla contestazione pacifica di parecchi manifestanti pro-Palestina (situati in particolare lungo la Clarastraße, tratto conclusivo del percorso dei tram, con largo dispiego di bandiere e cartelloni). Unico impedimento al regolare svolgimento del Carpet, subito rilanciato da tutti i media, è stato legato a un manifestante che si è seduto per terra cercando di impedire il passaggio del tram israeliano ed è stato portato via di peso dalla polizia svizzera, mentre un altro è stato ripreso mimando il gesto del taglio della gola in direzione dell’artista israeliana Yuval Raphael ed ha provocato una protesta ufficiale della delegazione all’EBU.
All’interno della Messe Basel, i delegati stampa sono stati smistati in vari “pool” corrispondenti al tipo di media rappresentato (io ero nel numero 6, destinato come il 5 agli accreditati M1/M2/M3 ovvero media tradizionali di forma internazionale, nazionale e locale). Non tutti gli artisti, però, sono arrivati fino a lì. In seguito ci è stato spiegato che il passaggio in sala stampa non era obbligatorio, dettaglio che ha lasciato piuttosto perplessi diversi accreditati italiani, soprattutto dopo l’annuncio che Lucio Corsi non si sarebbe presentato. Alla fine si è concesso per pochi minuti – parte dei quali purtroppo è stata sprecata in selfie “di rito” richiesti dagli stessi giornalisti, consuetudine che trovo poco professionale in contesti dove l’accesso agli artisti è limitato e tutti dovrebbero avere la possibilità di svolgere il proprio lavoro.
(Altre nazioni che non ricordo di aver visto passare: San Marino, Spagna, le favorite Francia e Austria. Al momento non ci ho dato troppo peso, ma ripensandoci a mente fredda, viene spontaneo chiedersi se questa libertà concessa alle delegazioni – decidere se affrontare o meno la media room – non sia stata anche un modo piuttosto “furbo” per permettere a Israele di presenziare al Carpet ed evitare il contatto diretto con i giornalisti.)
Uscito piuttosto soddisfatto dal Messe Basel sono stato raggiunto dalla notizia “calcistica” della vittoria del Basilea per 5-2 sul campo del Lugano, che sanciva matematicamente la conquista della Super League da parte dei rossoblù. Dettaglio che inizialmente mi era sembrato marginale, ma che ha assunto tutt’altro peso quando ho realizzato che i festeggiamenti dei tifosi avevano già invaso le vie del centro, bloccando temporaneamente il servizio dei mezzi pubblici. Mi sono quindi trovato costretto a rientrare a piedi, in fretta e furia, per riuscire a registrare in tempo l’intervista via Zoom che avevo organizzato prima della partenza con Carl-Henrik Wahl – in attesa di quelle che contavo di ottenere in settimana.
Il lunedì l’attenzione si è spostata sulla St. Jakobshalle, dove si sono tenute le prove generali della prima semifinale e sono iniziati i primi veri contatti e scambi di opinioni tra accreditati, italiani e non. Fin da subito ho percepito una dinamica piuttosto diversa rispetto agli altri Eurovision che ho vissuto in presenza: la presunta corsa a due tra Svezia e Austria, raccontata dalle scommesse, sembrava non convincere granché gli addetti ai lavori. Al contrario, prevaleva un diffuso scetticismo verso le “favorite d’obbligo” – ci aggiungo anche Francia e Paesi Bassi – e una sensazione generale che ci fosse spazio per una o più sorprese.
I pronostici andavano spesso ad abbinare una candidata “prevedibile” (la Francia con Maman era la più gettonata) e una “quota sorpresa”, che sorprendentemente – ma nemmeno troppo – era quasi sempre rappresentata dall’Albania. Dopo le prove vere e proprie, la solita noia e la voglia matta di trovare alternative hanno portato alcuni a spingersi fino a parlare apertamente di Zjerm come possibile outsider per la vittoria. Altri, invece, erano rimasti affascinati dalla Svizzera e già fantasticavano un improbabile bis.
Nel frattempo, la Svezia – da sempre favorita – ha dissipato gran parte dei dubbi generati dallo snippet diffuso in precedenza (“non si sentonoooo le vociiiiii!!1!” o “è tutto troppo arancioneeeeee!!!1!1!”), riuscendo comunque a vincere, seppur di misura, il primo Press Poll. La sensazione che ho avuto è che, al netto delle perplessità, la maggioranza della sala stampa non fosse ancora pronta a scendere dal carro di Bara bada bastu.
Sull’Italia e Volevo essere un duro, sia durante le prove pomeridiane in arena che la sera guardando dal maxischermo, ho avuto fin da subito la sensazione che l’obiettivo della top10 finale fosse assolutamente alla portata – impressione che mi sono portato dietro per tutto il resto della settimana. A domanda specifica, i pochi colleghi stranieri con cui ho parlato sembravano, in realtà, persino più ottimisti dei giornalisti italiani (soprattutto quelli che solitamente non si occupano di Eurovision) secondo cui l’esibizione funzionava ma il brano e il messaggio rischiavano di “non essere capiti”.
Con tutto che – volendo essere onesti – questa avrebbe dovuto essere considerata una responsabilità dell’artista e del team creativo e non una scusa per assolverli a priori, personalmente ho trovato il gimmick dei sottotitoli azzeccato fin dal primo momento, e il tanto discusso momento dell’armonica ben pensato e d’impatto: un elemento visivo e sonoro forte, in grado di colpire il pubblico medio forse più di tante altre performance ben più sponsorizzate. Il mio unico vero dubbio riguardava la memorabilità del pacchetto complessivo, soprattutto nel caso in cui avesse pescato la first half e si fosse trovato a cantare tra i primi sei o sette – non proprio la posizione più fortunata. E poi, naturalmente, la domanda eterna: dando per scontato che una nicchia del pubblico dell’Eurovision potesse essere effettivamente interessata alla proposta di Lucio, quanto numerosa e diffusa avrebbe potuto essere?
Manco a dirlo, su Twitter e dintorni – soprattutto nei covi abituali degli eurofan italiani -piovevano critiche e scetticismo. E pioveva letteralmente anche fuori dalla St. Jakobshalle, per l’unica volta in tutta la settimana: uno scroscio improvviso e impietoso che ha costretto me e Marta Cagnola (Radio 24) a una corsa disperata per intercettare l’autobus 36, la cui fermata era stata spostata più avanti lungo la Brüglingerstraße per facilitare il deflusso del pubblico uscito dal jury show.
Archiviata la prima semifinale e i suoi risultati shock (ma ci torneremo, soprattutto sulla disastrosa eliminazione del Belgio e di Cipro), mercoledì 14 è stata un’altra giornata cruciale: per la prima volta avremmo visto sul palco le esibizioni delle 16 nazioni in gara nella seconda semifinale, oltre a quelle delle tre “Big 5” rimaste: un menu decisamente ricco che vedeva sul piatto le favorite Austria e Francia più la mina vagante Israele. JJ ha saputo zittire in parte i tanti scettici (me compreso), ma la vera vincitrice di giornata è stata senza dubbio Erika Vikman per la Finlandia: la sua performance ha iniziato a farla risalire con decisione nella classifica delle scommesse, facendola emergere come l’ennesima possibile “candidata di compromesso” in un campo di favoriti sempre più frammentato. Ich komme ha poi vinto di misura il sondaggio del pubblico del family show, con tre preferenze in più rispetto a una comunque solidissima Wasted Love, che ha confermato la buona impressione lasciata fin dalle prime prove.
A posteriori, uno degli eventi spartiacque dell’ESC 2025 si è verificato giovedì pomeriggio, mentre mi trovavo al Novotel con il resto degli accreditati italiani per una conferenza-tavola rotonda di mezz’ora con Lucio Corsi – incontro che seguiva l’altro appuntamento organizzato mercoledì pomeriggio da RAI e dal suo team ovvero l’esibizione sul palco dell’EuroVillage, dove Lucio e Tommaso avevano proposto Volevo essere un duro e Francis Delacroix in versione “unplugged” davanti a un pubblico folto e caloroso, composto da italiani, italofoni e semplici eurofan. Il comunicato stampa diffuso dal broadcaster svizzero SRG SSR parlava di una contestazione avvenuta in arena durante il family show, con l’esibizione di Israele inficiata da sei disturbatori con bandiere oversize e fischietti.
Lì per lì non mi è sembrato che la stampa eurovisiva abbia dato troppo peso alla questione – un atteggiamento, va detto, in linea con l’impegno condiviso (e più che sensato) di non amplificare inutilmente l’azione degli oppositori più rumorosi, evitando di fare il gioco di KAN e della delegazione israeliana, come purtroppo era successo nel 2024. Diverso il discorso per la stampa generalista, che è uscita quasi subito in tutta Europa (e oltre) con titoli e articoli che davano ampio spazio alla protesta e la collegavano direttamente al corteo pro-Palestina svoltosi in centro a Basilea la sera precedente. Con l’avvicinarsi della seconda semifinale, e con un certo clima che sembrava tornare a farsi carico di tensioni esterne, per un istante nella mia testa si sono riaffacciati i fantasmi di Malmö 2024.
Eppure anche la seconda semifinale è scivolata via, accompagnata da un clima di euforia generale per il ritorno in finale di Malta e Danimarca – indimenticabile la scena del capodelegazione danese (nonché produttore esecutivo del DMGP) Erik Struve Hansen, visibilmente commosso mentre accompagnava Sissal in sala stampa per due rapide battute con i giornalisti danesi.
Le ultime quarantotto ore prima della finale non hanno riservato particolari scossoni. In sala stampa, l’idea di una possibile vittoria della Francia ha iniziato a consolidarsi, complice la vittoria nel Press Poll e un solido quinto posto nell’Audience Poll del jury show di venerdì sera. Nelle scommesse, a guadagnare terreno erano soprattutto Francia e Finlandia – quest’ultima spinta dall’ottimo riscontro nei sondaggi, nonostante un problema tecnico durante la prova del pomeriggio che aveva impedito di allestire in tempo il microfono-razzo, elemento centrale della sua performance – mentre qualche timido movimento si registrava anche intorno all’Albania, oggetto di nuove puntate da parte dei più ottimisti. La Svezia, però, restava inossidabile in vetta, con probabilità di vittoria ormai superiori al 40%, mentre l’Austria, ancora seconda, si manteneva stabile intorno al 20%.
In ogni caso la giornata della finale sembrava avviata sui binari migliori: l’intervista con Anderz Wrethov, organizzata e realizzata all’ultimo secondo utile, aveva aggiunto una soddisfazione personale a un pomeriggio fatto di ultimi giri di pronostici, previsioni e confronti sparsi. L’atmosfera era quella di un’attesa carica di aspettative, ma apparentemente priva di tutta la tensione e la negatività dell’anno scorso…
…finché non è iniziato il giro dei collegamenti con le varie giurie, che ha subito dipinto un quadro ben più imprevedibile di quanto ci eravamo immaginati. Le fan favorite (Finlandia e Albania in primis) sono uscite rapidamente dai radar, mentre la Svezia favorita dai bookmakers arrancava visibilmente. Nessuna delle tre indiziate a dominare tra i giurati (Austria, Svizzera e Francia) sembrava intercettare un plebiscito simile a quello raccolto da Nemo nel 2024 o Loreen l’anno prima. Paradossalmente, facendo i soliti conti della serva, a emergere nei primi conteggi era proprio l’Estonia: Tommy Cash si manteneva stabilmente nella metà sinistra della classifica e in alcuni momenti si piazzava persino davanti ai KAJ, suoi principali rivali in ottica televoto. Il tavolo italiano, nel frattempo, si sgolava per i tanti 12 collezionati da Lucio Corsi, che certificavano quasi matematicamente il raggiungimento della top10 già a metà del blocco giurie.
Rimanevano da leggere i punti del televoto e la mia impressione, guardando il tabellone, era che fossero sul tavolo davvero tutti gli scenari: il distacco fra “cacciatrici” e “inseguitrici” era tutto sommato contenuto e se le preferite delle giurie fossero state unanimemente bocciate dal televoto, avrebbero potuto rientrare in corsa anche Svezia, Estonia, Finlandia e paradossalmente persino l’Italia (quarta provvisoria e vicinissima alla zona podio).
Nessuno, però, si aspettava i 297 punti raccolti da Israele, con New Day Will Rise che dal 15° posto andava a scalare fino in vetta e si difendeva dall’attacco di tutte le rivali successive, a partire dalla stessa Estonia che si fermava un solo punto sotto. Da lì in poi, ammetto, ricordo solo il silenzio e l’incredulità che sono calati sulla sala stampa, montando sempre più ad ogni nazione che veniva annunciata. Passavano i minuti e l’evento che per un anno intero avevamo esorcizzato e per assurdo era sembrato molto più lontano rispetto a Malmö – la vittoria di Israele, che per i motivi geopolitici ben noti avrebbe significato inevitabilmente la fine dell’Eurovision – rimaneva in piedi, saldo come la stella di David in cima al tabellone. La Svezia non raccoglieva abbastanza punti da superare il duo di testa, l’Italia con 97 punti di televoto si assicurava quantomeno la 7° posizione finale poi diventata 5° per il tracollo generale di Paesi Bassi, Francia e Svizzera.
Ora, sappiamo bene che arrivati al momento dello split-screen è matematicamente scontato capire chi ha vinto, semplicemente sottraendo dal totale dei punti assegnabili quelli già chiamati dalle conduttrici. Non appena la Svizzera ha incassato i suoi zero punti, il gruppo di giornalisti israeliani avanti a me di qualche fila si è alzato in piedi per festeggiare, facendomi immediatamente pensare che avessero fatto i conti e già sapessero che JJ non aveva ottenuto i 100 punti necessari a sopravanzare Yuval. Non era così: nel giro di pochi secondi hanno iniziato ad accumularsi sul mio laptop le notifiche di chi festeggiava la vittoria austriaca, che proprio in quel momento veniva assegnata nel giubilo pressoché unanime della sala stampa.
E quindi sì, vittoria dell’Austria: il più classico dei tutto è bene quel che finisce bene, giusto? Il quinto posto dell’Italia da festeggiare insieme? Ci si vede a Vienna, siamo una grande famiglia, united by music, auguri e buon ritorno a casa?
Onestamente, l’ultima cosa di cui avevo voglia era di festeggiare l’ennesimo scampato pericolo, e tantomeno di restare in giro per la conferenza stampa del vincitore. Ho chiuso i miei ultimi pezzi in fretta, ho raccolto le mie cose e sono tornato a piedi verso l’Airbnb, sfogando la frustrazione con una raffica di vocali al mio amico Pablo, che da Miami aveva seguito tutto quanto in diretta…
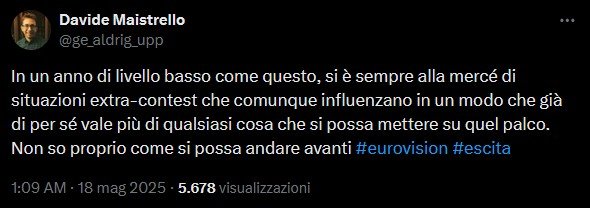
IL VINCITORE
Dico subito che uno dei motivi per cui ho impiegato diverse ore a raccapezzarmi della vittoria dell’Austria e di JJ è perché non l’avevo mai vissuta come uno scenario credibile. Wasted Love mi è piaciuta dal primo ascolto, pur non figurando tra le mie favorite dell’edizione: ho sempre pensato che fosse una canzone interessante, ben costruita e abbinata a un interprete magari non super carismatico ma in grado di renderle giustizia con la performance dal vivo. E però, la mia impressione era che ÖRF avesse scelto l’anno peggiore possibile per proporre in Europa la ricetta dell’opera pop: non abbiamo detto e ripetuto per anni che due brani simili non vincono due edizioni consecutive (per lo meno dal trittico 2003-05, quando il pop femminile in salsa etnica-mediterranea-Shakira-dei-poveri spopolava e una dopo l’altra trionfavano Sertab Erener, Ruslana Lyzhychko e Helena Paparizou)? Certo, The Code e Wasted Love non erano del tutto sovrapponibili, ma nascevano dalla stessa formula e dallo stesso “universo” – quello del songwriting camp organizzato dal Mr. Eurovision svizzero, il produttore e musicista Pele Loriano – e onestamente non c’erano garanzie che il pubblico avrebbe colto la differenza.
Eppure, più volte durante la settimana mi sono trovato a pensare di stare vivendo un mezzo déjà vu, perché il percorso di JJ è stato davvero sovrapponibile in tanti aspetti rispetto a quello di Nemo. Un po’ come successo a Malmö con The Code, arrivavo alla prima prova del mercoledì pieno di pregiudizi e già immaginavo che l’hype (dettato ovviamente dallo spasmodico appoggiarsi degli scommettitori su pattern già “familiari” e conosciuti) si sarebbe sciolto alla prova del live. Mi sono ricreduto immediatamente.
A fare la differenza è indubbiamente stata la performance messa in piedi dal creative director Sergio Jaén: il “naufragio” di JJ e soprattutto il crescendo cinematico degli ultimi 30″, fino all’ultimo acuto con il mezzo giro del faro proiettato a LED ad illuminare l’arena (forse il mio shot preferito di tutta l’edizione), hanno caratterizzato un pacchetto che fin da subito ho pensato potesse garantirsi un televoto consistente e valevole quantomeno una piazza d’onore. Vederla in vittoria era complesso perché, sempre facendo i conti della serva, non ci si stava con la matematica: JJ avrebbe dovuto seguire lo stesso winning path di Nemo, con 300+ punti di giuria e 200+ di televoto, per arrivare ai 500/520 circa dove mettevo la soglia-vittoria. Con tante proposte credibili che puntavano allo stesso obiettivo (Francia, Svizzera, Paesi Bassi), non vedevo perché le giurie dovessero buttarsi sulla più simile a quella premiata dodici mesi fa.
La storia dice che il ragionamento era giusto a livello teorico: il livello dell’edizione era ancora più basso e il voto più frammentato di quanto era stato paventato nei mesi scorsi, e la vittoria austriaca è arrivata con 436 punti, di gran lunga il punteggio più basso da quando esiste questo metodo di voto. JJ ha vinto in un percorso in stile “Nemo 2, ma meno” facendo 1° alle giurie e 4° al televoto (The Code era stata 1° e 5°) e proprio come Svizzera 2024 non ha fatto particolarmente bene nella semifinale di giovedì (addirittura quinto su 16).
É un vincitore che fa bene al concorso? Per me è una domanda sbagliata da porsi, non trovo giusto sminuire a posteriori una vittoria legittima e conquistata dove conta e cioè sul palco dell’ESC. Il riscontro commerciale, casomai, può essere un fattore che rivaluta una vittoria “controversa” (tipo quella di Loreen nel 2023) ma non può diventare un requisito in assenza del quale si può appiccicare al vincitore l’etichetta di flop. Posto che i Måneskin e gli altri successi dell’era-TikTok hanno imposto uno standard insostenibile, e che la stessa narrazione di Nemo sia quella di un “vincitore flop” al netto dei 97 milioni di streaming raccolti in un anno da The Code, la verità è che se pure Wasted Love si mantenesse (come è probabile) sotto queste cifre, non si può negare che all’interno di questa edizione non c’erano brani a cui è stata privata la possibilità di diventare veri e propri crack a livello commerciale.
ITALIA: LA RIVINCITA DI “QUELLI NORMALI”
Quella che su Twitter ho definito un’annata “di transizione” per la delegazione italiana – complice la quasi totale irrilevanza di Volevo essere un duro nella narrazione eurovisiva di questa stagione e il fatto che, per la prima volta dopo anni, l’Italia non sia mai stata realmente in corsa né per la vittoria né per il podio – si è chiusa con un quinto posto che, oggettivamente, è andato oltre ogni più rosea aspettativa. Questo ovviamente non significa che non ci sia nulla da analizzare – anzi vale forse la pena proprio adesso, a mente fredda, iniziare a dissezionare ciò che non mi è piaciuto e che posso riassumere in “tutto ciò cho visto e percepito al di fuori delle due esibizioni di Lucio sul palco di Basilea”.
La storia parte ovviamente da metà febbraio e dal “gran rifiuto” di Olly a rappresentare l’Italia all’ESC dopo la sua vittoria al Festival di Sanremo – scelta che, per il regolamento imposto quest’anno, passava il titolo nelle mani del secondo classificato e cioè proprio di Lucio Corsi. Pur essendo stata una scelta presa in piena autonomia dall’artista, al di là delle polemiche scoppiate sui social dopo il trionfo di Balorda nostalgia, non mi è sembrato che qualcuno – nemmeno tra le fan più affezionate di Olly – si sia stracciato le vesti all’idea di non vederlo a Basilea. Anzi, semmai il sentiment prevalente era che la rinuncia fosse quasi un atto dovuto: per non deludere i fan che avevano già comprato i biglietti del suo tour di maggio, ma anche per evitargli un palco su cui avrebbe dovuto esibirsi senza l’ausilio dell’autotune (a scanso di equivoci: problema che IMHO si sarebbe potuto risolvere tranquillamente con un paio di coristi). Lucio Corsi era uscito da Sanremo come vincitore morale e nuovo personaggio di richiamo del panorama musicale italiano, e non era raro leggere persone che peroravano la sua causa ritenendolo “più adatto” al palco eurovisivo.
Dal 22 febbraio, giorno in cui il rifiuto di Olly è stato messo nero su bianco, questa situazione si è totalmente ribaltata e la coscienza collettiva – aizzata da buona parte della stampa mainstream, musicale e non – si è affrettata a bollare Lucio come “non adatto” alla kermesse europea in modo a mio avviso anche un po’ subdolo e manipolatore. Non saprei descrivere in altro modo, in effetti, gli articoli letti in cui Volevo essere un duro veniva soppiantata da Tutta l’Italia di Gabry Ponte (jingle del Festival di Sanremo portato a rappresentare San Marino sull’onda dell’euforia collettiva) nel ruolo di “vera entry italiana” all’Eurovision 2025, e i mille endorsement spassionati ricevuti dal DJ torinese nel suo percorso di avvicinamento a Basilea.
Scriveva Alice Maria Oliveri su Rivista Studio il 7 marzo, poche ore prima della vittoria di Tutta l’Italia al San Marino Song Contest: “Altro che Lucio Corsi e altro che estetica rohrwacheriana, ali di farfalle, Piccolo Mondo Antico e stazione di Bolo. All’Eurovision del 2025, in questo clima disteso da Terza guerra mondiale, chi altro se non l’uomo che ha esportato il meglio della nostra indole discotecara può non solo rappresentarci, ma anche vincere con la sua hit techno-taranta infarcita di luoghi comuni e stereotipi? (…) Insomma, Gabry Ponte è senza ombra di dubbio, prima ancora di partecipare, il soldato di cui la nostra povera patria necessita per trionfare anche in quel contesto di caos multiculturale e kitsch che è l’Eurovision…”
Non sono del tutto sicuro che si fosse capito che la “povera patria” rappresentata da Ponte fosse non già l’Italia ma la Serenissima Repubblica di San Marino, né mi è del tutto chiaro perché si sia sentita l’urgenza di spingere così apertamente la sua candidatura (anche se, ovviamente, i miei sospetti li ho). Fatto sta che il mood generale, da quel momento in poi, è stato di scarso entusiasmo nei confronti di Lucio e della delegazione italiana. In un anno in cui in Italia si è parlato tantissimo di Eurovision, paradossalmente sono state Tutta l’Italia e Espresso Macchiato a essere percepite come le nostre portacolori, a discapito del progetto effettivamente selezionato per rappresentarci.
(Meriterebbe/meriterà trattazione separata, come l’esegesi della partecipazione di San Marino, anche il pianto greco durato MESI sulla necessità di separare Festival di Sanremo ed Eurovision nella scelta del rappresentante italiano – fomentato anche dalla nostra co-commentatrice BigMama, nonché da un sondaggio informale di Trash Italiano dove l’89% si dichiarava d’accordo con lei).
Per onestà intellettuale, va anche detto che lo stesso Lucio non ha dato l’impressione di essere particolarmente coinvolto nella promozione della sua partecipazione all’Eurovision. Non solo è stata annullata – senza alcuna spiegazione ufficiale – la sua presenza al pre-party di Madrid, dove era stato inizialmente annunciato, ma perfino per la rubrica di YouTube Eurovision: A Little Bit More (dedicata a contenuti extra e performance esclusive) non è stato realizzato alcun video ad hoc. Al suo posto, sono stati proposti un live di Situazione complicata registrato in concerto e una versione “unplugged” di Volevo essere un duro introdotta nientemeno che da Mara Venier allo speciale sanremese di Domenica in.
In questo contesto, era quasi inevitabile iniziare a chiedersi quanto davvero Lucio fosse interessato alla manifestazione in sé: dubbi che riemergevano puntualmente ogni volta che uno degli altri partecipanti sottolineava – spesso tra le righe, talvolta con malcelata ironia – che lui era l’unico artista in gara a non essere ancora entrato in contatto con nessuno, e che risultava escluso persino dal famigerato gruppo WhatsApp dei concorrenti. (Non so esattamente perché questa informazione sia diventata rilevante nella narrazione di un contest musicale, ma tant’è: siamo arrivati a questo punto e io mi limito a riportarlo.)
Penso di avere avuto la mia risposta nella “tavola rotonda” con gli accreditati stampa del giovedì pomeriggio, dove per una volta tanto si è parlato quasi solo di Eurovision anche in termini tecnici e Lucio ha spiegato da subito, in maniera molto dettagliata, come lui e Tommaso Ottomano erano arrivati a concepire la trasposizione della performance sanremese sul palco dell’ESC.
L’impressione che ho avuto è che Lucio fosse estremamente concentrato sull’esperienza in sé: portare se stesso, la sua musica e la sua visione artistica sul palco europeo, e farlo nel miglior modo possibile nei tre minuti a disposizione – senza compromessi, senza mediazioni, e soprattutto senza tradire o snaturare la propria poetica. La messa in scena, realizzata da Alberto Manzone per lo studio di direzione creativa Galattico, ha decisamente colto nel segno: se tanti hanno criticato la troppa staticità, i cambi di inquadratura molto lenti o i prop portati in scena (i due finti amplificatori e il lunghissimo pianoforte) la realtà è che a posteriori il puntare sulla “musica vera” e su una semplicità curata ed elegante nella sua coerenza si è rivelato vincente all’interno di un’edizione piena di “circhi” e proposte iper-costruite e strutturate.
Personalmente, ho sempre pensato che Lucio fosse un personaggio molto spendibile in ottica eurovisiva. Se in una selezione nazionale come Sanremo – che, paradossalmente, è spesso più difficile e complicata da vincere dello stesso Eurovision – un artista quasi sconosciuto riesce a emergere fino ad arrivare a uno scarto minimo dallo scettro finale (0,4%, per l’esattezza), significa che dentro quella proposta c’è qualcosa di fortissimo e che necessariamente va individuato, valorizzato e fatto passare nel modo giusto sul palco europeo. E direi che ci si è riusciti, molto meglio di quanto ci si potesse aspettare: la scelta – furbissima – di suonare l’armonica a bocca ha sfruttato alla perfezione un loophole del regolamento (che consente strumenti dal vivo purché non richiedano amplificazione), trasformando un dettaglio tecnico in un momento di grande impatto emotivo e scenico.
Ma soprattutto, il vero colpo di genio (e che penso farà scuola, venendo replicato da molte delegazioni negli anni a venire) è stato l’uso dei sottotitoli a video. Un espediente semplice ma potentissimo, che ha permesso a Volevo essere un duro di raccontare il proprio messaggio fino in fondo, superando la barriera linguistica senza tradirsi. L’idea che i sottotitoli potessero risultare troppo didascalici è stata, secondo me, completamente smentita dai fatti. Hanno funzionato eccome: qui, come già era successo con Non mi avete fatto niente, e – in forma più discreta, sugli schermi LED – anche con Soldi. È una trovata così intelligente e al tempo stesso così banale nella sua semplicità, che viene quasi da chiedersi perché ci siamo arrivati solo noi (e pochi altri, come la Serbia del 2022 con In corpore sano).
In sostanza, il 5° posto di Lucio Corsi resta un risultato migliore del migliore scenario ipotizzabile, ma a posteriori mi lascia l’impressione che ci stia quasi stretto e che se ci avessimo creduto un minimo in più in un anno bislacco come questo anche il podio avrebbe potuto essere alla portata. L’idea che mi sono fatto, giusta o sbagliata che sia – ma supportata dalle interazioni che ho avuto a Basilea e che sarebbe indelicato riportare – è che RAI in primis non credesse più di tanto in Lucio (e in ogni caso: meno di Gabry Ponte, visto come la vera carta da top10 su cui “cadere” e in caso poi attestarsi). E d’altra parte, cosa si sarebbe potuto fare in più? Ovviamente, con artisti affermati e già strutturati, non si può pretendere una gestione capillare come quella che si vede in Paesi che mandano esordienti. Ma è evidente che passare totalmente inosservati nei due mesi che precedono il contest porta inevitabilmente a essere sottovalutati, a non far parlare di sé dentro e fuori la bolla eurovisiva, e a venire tutelati meno di altri dai produttori nel momento cruciale della composizione del running order. In un’edizione in cui l’Italia tornerà a giocarsi seriamente la vittoria – ed è solo questione di tempo – questi saranno aspetti che sarà rischioso ignorare.
Detto questo, una squadra di persone completamente avulse al contesto dell’ESC ha saputo mettere in scena, paradossalmente, una performance molto più funzionale al palco eurovisivo di tante nazioni che si sono affidate ai creativi più in voga nella “bolla”. É un risultato enorme per l’Italia eurovisiva e non posso fare altro che togliermi il cappello.
ISRAELE E LA MOBILITAZIONE DEL PUBBLICO OCCASIONALE
“Non simpatizzo con Hamas né con il governo di Netanyahu o l’IDF, simpatizzo con i palestinesi che ripudiano il terrorismo islamico e con gli israeliani che ripudiano il massacro del popolo palestinese. In un mondo ideale, mi piacerebbe che lo Stato di Israele conviva pacificamente con uno Stato indipendente di Palestina (con termini analoghi a quelli degli accordi di Annapolis), con USA e determinate nazioni della Lega araba ad agire come garanti della convivenza civile.”
La mia posizione sul conflitto israelo-palestinese era questa un anno fa e non è cambiata. Perché lo scrivo? Perché è necessario ogni volta che si affronta questo tema, perché anche all’ESC dopo l’anno che abbiamo passato e l’orrore che pervade la striscia di Gaza da due anni e mezzo c’è chi non capisce perché la partecipazione di Israele venga considerata quantomeno controversa – e perché, soprattutto, molti continuano a sorprendersi del fatto che KAN sia regolarmente in gara, mentre i broadcaster di Russia e Bielorussia sono stati sospesi a tempo indeterminato. Fare gli assolutisti darebbe motivo al fandom di cancellare dalla griglia di partenza abbastanza nazioni da rendere totalmente inutili le semifinali, eppure mi sembra chiaro che dopo i fatti di quest’anno il tentativo di EBU di favorire la “convivenza civile” abbia rischiato di trasformarsi in un gigantesco autogol.
La mia principale preoccupazione, in vista della settimana di Basilea, era che la parte più incendiaria del fandom non avesse interiorizzato la lezione di Malmö 2024: ogni forma di contestazione troppo rumorosa non avrebbe fatto altro che giocare a favore di Israele, offrendo su un piatto d’argento visibilità mediatica e l’occasione di rafforzare la propria narrazione vittimistica. Fortunatamente, credo che questa consapevolezza sia stata condivisa dalla maggioranza, e che l’atteggiamento generale sia stato meno teso e più lucido. In sala stampa ho visto più persone disposte ad applaudire Yuval rispetto a quanto accaduto con Eden lo scorso anno, al di là della solita claque di fedelissimi piazzata in prima fila – con bandiere e sciarpe biancoblù, a sostegno dell’artista durante le prove in arena. Il clima complessivo mi è sembrato più contenuto e meno incline ad alimentare la polarizzazione a suon di gesti eclatanti.
Dopodiché, non ci si può fare carico delle azioni di ogni singolo spettatore – e come ho già detto prima, è innegabile che si siano verificate contestazioni men che pacifiche sia durante il Turquoise Carpet che durante le prove. Questi gesti vengono immediatamente rilanciati sui social, stigmatizzati e dati in pasto alla stampa mainstream che logicamente è costretta a parlarne perché è una notizia – come del resto lo era il fatto che Israele si fosse presentato in Svizzera con un’artista, Yuval Raphael, che prima di tutto era una sopravvissuta della strage del festival musicale Nova (storia talmente forte da meritarsi un servizio monografico del Tg1 a firma Maria Gianniti). E nel momento in cui esce dalla bolla eurovisiva ed entra in quella degli “occasionali”, improvvisamente inizia a raggiungere e a fare discutere una fetta di pubblico a cui della musica, della gara e delle performance non può fregare di meno.
Israele ha puntato tutte le fiches sulla mobilitazione estrema di questo pubblico, facendosi forza dell’idea che la causa filo-israeliana potesse muovere una fetta più ampia del supporto di ogni altra canzone – ed è esattamente ciò che è accaduto, proprio come nel 2024. Basti guardare i numeri: 12 delle 15 nazioni che un anno fa avevano assegnato 12 punti a Eden Golan (Australia, Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Resto del Mondo, Spagna, Svezia, Svizzera) lo hanno fatto anche quest’anno con Yuval Raphael.
È rassicurante e probabilmente comodo pensare che tutto ciò sia frutto di un televoto “truccato”, alimentato dall’acquisto massivo di SIM – ma è un’interpretazione che, semplicemente, non regge alla prova dei fatti. Se Israele avesse davvero orchestrato una strategia simile, perché mai avrebbe concentrato i massimi punteggi proprio nelle nazioni più popolose e con i bacini di voto più ampi e difficili da “infiltrare”? La verità è molto più lineare – e, sotto certi aspetti, più potente: in tutta Europa, le comunità ebraiche hanno saputo mobilitarsi in modo assolutamente efficace e capillare. Migliaia di persone hanno scelto di votare attivamente – anche con più dispositivi, tra smartphone e carte di credito – per esprimere il proprio supporto a una causa che sentono come personale, urgente e identitaria. E questo va detto con chiarezza: finché nessuno dimostra che questi voti siano stati direttamente finanziati da un governo, non c’è assolutamente nulla e sottolineo NULLA di illegale in tutto ciò.
Questo, però, non significa che sia una situazione sostenibile e non ci sia un problema urgente da risolvere. L’Eurovision vive da quattro anni una situazione che possiamo raccontare come l’onda lunga di Torino 2022: in quell’occasione, si decise che il plebiscito del televoto europeo a favore della causa ucraina potesse essere interpretato come un messaggio forte, simbolicamente positivo (un’Europa compatta, metaforicamente “schierata” accanto all’Ucraina invasa, in un momento di crisi profonda). Era una narrazione potente, utile a proiettare l’immagine dell’Eurovision come qualcosa di più di un semplice concorso musicale. Ma quel messaggio, per quanto emotivamente comprensibile nei giorni di Torino, portava con sé delle conseguenze.
Col tempo, abbiamo visto che il sostegno europeo al popolo ucraino era molto più fragile e condizionato di quanto il voto ai Kalush Orchestra avesse lasciato intendere. E soprattutto, che l’aver aperto quella porta – quella della vittoria per causa – ha creato un precedente. Uno spazio che altre cause (più giuste, meno giuste, non sta a me stabilirlo) si sono sentite legittimate a occupare. E non serve nemmeno un plebiscito: in un contesto frammentato come quello di quest’anno, è sufficiente che una causa riesca a mobilitare anche solo il 10–15% del televoto di una nazione per garantire alla propria entry un posto nella top3 di quel Paese. Ed è proprio questo il nodo centrale: in un sistema dove nessuna canzone raccoglie maggioranze vere, una minoranza compatta, determinata e motivata può spostare gli equilibri in modo decisivo.
Una parte consistente di chi ha votato New Day Will Rise non lo ha fatto per un reale entusiasmo nei confronti della canzone – che, va detto, in patria ha smosso molto meno rispetto a Hurricane/October Rain, brano diventato un vero e proprio inno popolare nel 2024 ed eseguito in numerosi eventi legati alla richiesta di liberazione degli ostaggi. Il voto a Yuval Raphael ha rappresentato per molti un gesto simbolico: un modo per sostenere attivamente la propria patria spirituale e, al tempo stesso, segnalare al resto d’Europa l’esistenza di un forte quanto “silenzioso” sostegno a Israele.
Un meccanismo che, in fondo, non è così diverso da quello che da anni alimenta il voto di diaspora. Anche in questa edizione l’abbiamo visto chiaramente: Polonia, Albania, Grecia e Ucraina hanno superato abbondantemente i 100 punti al televoto proprio grazie alla mobilitazione delle rispettive comunità espatriate, in presenza di proposte competitive e identitarie (Zjerm, Asteromata) o di artisti molto seguiti in patria (Justyna Steczkowska, Ziferblat). L’Ucraina, in particolare, ha addirittura vinto la prima semifinale raccogliendo più punti di tutte le favorite della vigilia e continua a dimostrare una straordinaria capacità di mobilitazione, sostenuta da una rete vasta e coesa di rifugiati e simpatizzanti sparsi in tutta Europa.
Il risultato di Israele al televoto – e la successiva richiesta di chiarimenti avanzata da diversi broadcaster e governi europei – impongono una riflessione seria e urgente su un sistema di voto che, oggi più che mai, ha bisogno di essere riformato. Se l’Eurovision vuole davvero rimanere un concorso musicale competitivo e credibile, deve garantire condizioni il più possibile eque per tutte le 37 delegazioni in gara, che investono tempo, denaro e risorse significative per “competere in musica” ad armi pari.
Un primo passo potrebbe essere l’uniformazione delle regole di voto in tutta Europa: ridurre e standardizzare il numero di preferenze esprimibili per utenza (attualmente il tetto massimo è 20, ma ogni nazione può decidere per sé: in Italia, ad esempio, sono 5), eliminare del tutto la possibilità di votare tramite carta di credito e, soprattutto, ripristinare una finestra di voto limitata ai 15 minuti successivi a tutte le esibizioni, com’era negli anni 2000. Questo aiuterebbe a ridurre le strategie di voto coordinate, rendendo più difficile organizzarsi in anticipo per concentrare il televoto su una singola entry per motivi non musicali.
Qualcuno potrebbe obiettare che queste misure comporterebbero una perdita economica significativa rispetto allo status quo – ma alla luce di quanto successo tra Malmö e Basilea, e di quanto vicini siamo stati a una crisi di legittimità del concorso, non credo che l’EBU possa più permettersi di andare troppo per il sottile. Salvaguardare la credibilità dell’ Eurovision, nonché il rispetto per chi vi partecipa, deve tornare a essere la priorità assoluta.
ESTONIA: LA VINCITRICE MANCATA
Faccio coming out: non amo Espresso Macchiato, ho trovato l’intero pacchetto estremamente fastidioso e irritante dal momento che è stato annunciato tra i finalisti dello scorso Eesti Laul, ho tollerato a fatica la sua viralità in Italia e il modo in cui ha contribuito ad alimentare la narrazione giornalistica dell’ESC-baraccone trash di dubbio gusto – e però sono sempre stato convinto che Tommy Cash fosse la vera mina vagante di questo Eurovision, e che in un anno particolare e anomalo come questo si potessero creare le condizioni per vederlo persino in corsa per il podio. Nessuno ci credeva, e invece è andata proprio così – anzi, col senno di poi, credo che l’Estonia debba rimpiangere seriamente una vittoria che, guardando i numeri e il contesto generale, era più che possibile.
Il mio assunto di partenza era che Tommy non partecipasse all’Eurovision con intento del tutto benevolo. Considerata la sua nota affiliazione con Joost Klein – il rappresentante olandese squalificato poche ore prima della finale del 2024 – era plausibile immaginare che la sua presenza in gara potesse rappresentare una sorta di “vendetta” contro l’EBU, con lo scopo di screditare l’intera manifestazione dall’interno. Il brano United by Music, rilasciato da Joost e Tommy a febbraio 2025 e nel cui testo il rapper olandese dichiarava “fuck the EBU, I don’t want to go to court” riferendosi implicitamente ai fatti di Malmö, rendeva questa un’interpretazione più che plausibile. Ancora a dicembre, al primo ascolto del brano, la domanda che mi è venuta spontanea è stata: Tommy crede davvero che questa canzone possa replicare il supporto ricevuto da Cha Cha Cha o da Europapa, oppure sta solo puntando sul voto troll e su dinamiche extra-musicali per dimostrare che l’Eurovision è così poco credibile da permettergli di portare in vetta una canzone nonsense scritta in 15 minuti?
Eppure, vedere l’Italia comprata e venduta da Espresso Macchiato – con l’intero comparto giornalistico a boccheggiare dietro la storiella delle “nonnine di Ostuni” – mi ha fatto ricredere: quel progetto, dietro l’apparente nonsense, poggiava su basi ben più solide di quanto volessi ammettere all’inizio (ripensandoci, non poteva essere altrimenti: la canzone era firmata da Johannes Naukkarinen, uno dei deus ex machina di Cha Cha Cha). Con il senno di poi, era evidente che l’Estonia avesse un appeal molto più trasversale della Svezia, che in quel momento era favorita e veniva accreditata di stragi di televoto e giurie.
In tutto questo, un ulteriore colpo di fortuna è stato che Espresso Macchiato ha intercettato e anticipato il trend mondiale degli Italian brainrot, sorta di meme surreali generati con AI, spesso legati a cliché italiani esagerati e nonsense alcuni dei quali (l’onnipresente Ballerina Cappuccina) richiamavano esplicitamente il caffè. Tommy non ha nemmeno avuto bisogno di metterli in scena perché lui stesso era il brainrot: con una performance visivamente basica, ma stupidina e zany al punto giusto, è riuscito a catalizzare il voto della Gen Z e di quella fetta di pubblico che non prende l’Eurovision sul serio, ma lo guarda solo per riderne, commentarlo, e partecipare al caos virale del momento.
Al di là della consistente fetta di televoto portata via da Israele, l’Estonia ha pagato anche l’essere stata inserita in un runner ordine pessimo nella serata finale (#3, subito prima di Yuval Raphael in un maldestro e non riuscito tentativo di “svuotare” il suo televoto). La proposta di Tommy Cash è stata l’unica fra le favorite e outsider della vigilia a venire penalizzata in modo così marchiano, segno che comunque era vista come “sacrificabile” in favore della stessa Svezia che invece ha avuto in dote un ottimo #23. Non faceva comodo favorire l’Estonia in quanto nazione dell’Est, e sappiamo l’idiosincrasia della gestione attuale di EBU verso tutto ciò che sta al di là dell’ex-cortina di ferro? O non si voleva rischiare di premiare un personaggio ingombrante e potenzialmente scomodo? O si voleva semplicemente spianare la strada ai KAJ e al finale scontato previsto dagli scommettitori?
Visione forse un po’ complottista delle cose e ulteriormente complicata dalla pubblicazione dei risultati delle semifinali: a conti fatti, l’Estonia è arrivata quinta nella prima semifinale, appena cinque punti dietro la Svezia quarta – entrambe comunque dietro a Ucraina, Paesi Bassi e Albania (quest’ultima, peraltro, premiata dai produttori con il #26 nella finale). Ci sta pure che questo parametro non sia stato preso in considerazione, visto che un’altra conseguenza perniciosa del togliere le giurie dalle semifinali è stata evidentemente delegare l’intero risultato a una platea ridotta e composta principalmente da eurofan, che non sprecano voti sulle favorite – discorso che vale pure per l’Austria nella semi 2 – perché sanno che si qualificheranno comunque.
Eppure, non riesco a togliermi di testa un pensiero: un’Espresso Macchiato messa in fondo alla scaletta, nelle ultime 4-5 posizioni, avrebbe forse potuto avvicinarsi a quei 300 punti di televoto necessari a lanciarla verso il colpaccio che avrebbe davvero “rotto” gli schemi dell’ESC come lo conosciamo.
GLI SCONFITTI: FRANCIA, SVEZIA, SPAGNA E “CHI HA SERVITO FESSA”
🇫🇷 Perché in sala stampa regnava la convinzione che fosse l’anno buono per la Francia? Senza dubbio per il grandissimo investimento operato da France Télé, a partire dalla presentazione del brano tenutasi il 15 marzo, con i crismi della grande occasione e la solita aria di grandeur transalpina, allo Stade de France nell’intervallo di una partita del Sei Nazioni. Dopo esserci andati più o meno vicini con Barbara Pravi e Slimane, sembrava che i francesi avessero l’intento dichiarato di puntare al bersaglio grosso – e ancora di più dopo che è stato assoldato nel loro team Fredrik “Benke” Rydman, creative director e coreografo già artefice delle performance di Cha Cha Cha e The Code.
Nessuno si sarebbe potuto immaginare che a distruggere le velleità di Louane sarebbe stata proprio la messa in scena, e nella fattispecie uno shot in cui la cantante sembrava “in preda a una violenta reazione intestinale“. Possiamo tutti immaginare la reazione della delegazione francese nello scoprire che la performance curata nei minimi dettagli stava venendo messa alla berlina su tutti i social (con interazioni nell’ordine dei MILIONI di views) e paragonata a un attacco di diarrea, in un modo che non ha permesso in alcun modo di prendere seriamente l’intero pacchetto. E non esagero: sono le stesse parole che ha utilizzato nell’introdurre la canzone il commentatore di BBC Graham Norton, e non è un caso che la Francia si sia piazzata solo ventitreesima – il punteggio più basso in assoluto – nella graduatoria stilata dal televoto britannico.
Non so se noi accreditati stampa ci siamo rivelati complessivamente più maturi del pubblico medio per aver ignorato l’apparente crisi dispeptica o non averla recepita come tale, sta di fatto che Maman era di per sé un pezzo complesso per l’Eurovision (perché poco “gigione” rispetto ad altre entry francesi del passato, ma con l’handicap di un tema delicatissimo – la madre morta – che, pur affrontato con sincerità, rischiava di essere liquidato a torto come paraculo) e che si è trovato a doversi difendere dalla concorrenza diretta di Svizzera e Paesi Bassi – altri due brani in francese che hanno rosicchiato a Louane tanti punti sul fronte “giurie”, anche se a conti fatti il loro impatto sul televoto può essere definito trascurabile.
🇸🇪 Onestamente non riesco a non vedere il 4° posto di Bara bada bastu sotto una luce diversa da quella del flop. Che una proposta come quella dei KAJ – pur avendo messo la tradizionale “perfezione” svedese al servizio di un brano diverso dal solito, con tre interpreti vocalmente impeccabili e una realizzazione che avrebbe fatto impallidire qualunque joke entry eurovisiva del passato – venga comunque sconfitta alla prova dei fatti da Espresso Macchiato, a mio avviso dice moltissimo.
La medaglia di legno resta un piazzamento più che dignitoso per SVT, e si aggiunge a un ruolino di marcia solidissimo e che parla da sè – ma sarebbe arrivata comunque se non fosse stata supportata da un trattamento favorevole in termini di running order (#23) e da mesi di hype pompato da media e scommettitori? La sensazione resta quella di un progetto che arrivava a Basilea per vincere – e gli svedesi ci credevano tantissimo, in barba a tutte le scaramanzie – ma che invece si è scontrato con i propri limiti e in altre condizioni, o in un anno più forte, avrebbe potuto naufragare del tutto.
Il puzzle (già risolto dal sottoscritto in data 27 marzo u.s.) era più semplice del previsto: la sauna era un tema estremamente regionale e che non sarebbe stato recepito allo stesso modo in tutta Europa, come pure l’umorismo e la costruzione dell’act risultavano estremamente “nordici” e poco trasversali.
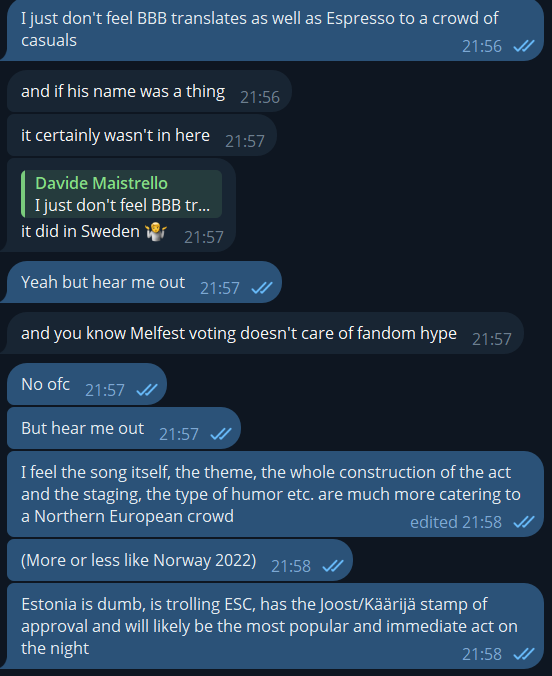
I risultati parlano chiaro: solo Danimarca, Estonia, Finlandia e Norvegia hanno assegnato il 12 alla Svezia – indizio evidente del fatto che il problema non fosse affatto peregrino, ma strutturale. In più, la fascia di pubblico interessata a premiare un act più scanzonato e “cazzone” ha scelto di farlo con l’Estonia, che quella linea l’ha abbracciata fino in fondo, invece di optare per il numero svedese, costruito fin troppo bene per sembrare davvero spontaneo. Continuo a ripensare a quella frase lanciata da Tommy Cash sul Turquoise Carpet, attaccando indirettamente i KAJ con un sorriso sprezzante: “A tutti piace il caffè, non a tutti piace la sauna”. All’epoca fu preso in giro dal fandom, ma aveva perfettamente ragione.
Voglio davvero bene a Bara bada bastu e credo sia una canzone speciale per la Svezia e arrivata nel momento in cui serviva una proposta “di rottura” da parte loro: era un rischio che andava corso e che ha pagato sicuramente più di quanto avrebbe fatto il riproporre un Måns Zelmerlöw già azzoppato dai vari scandali. Pur senza il podio, la Svezia ha mandato un messaggio chiaro – dimostrando di non avere timore di uscire dal proprio schema e provare strade nuove, senza rinunciare alla qualità produttiva che da sempre la contraddistingue. Nonostante tutto, SVT può guardare con fiducia al futuro: Karin Gunnarsson sta facendo un lavoro eccellente alla guida del Melodifestivalen, ed è scritto che da lì continueranno a emergere proposte competitive.
🇪🇸 Speravo che, nonostante tutto, la Spagna riuscisse a ritagliarsi una posizione decorosa “vendicando” in qualche modo la scelta di Melody – un’artista strutturata che ha messo in scena all’ESC la sua maturità artistica e la storia del suo percorso di carriera da bambina prodigio a diva valiente y poderosa. E invece no: per loro un altro 24° posto e a ruota i soliti lanci di stracci nel post-Eurovision. Melody, che non è certo nota per l’understatement, ha cavalcato la situazione con una serie di interviste al vetriolo contro la gestione di RTVE, mentre nel frattempo si è aperto un nuovo giro di piani incendiari per riformare il Benidorm Fest in vista della prossima edizione.
Credo che il giudizio dei posteri sarà benigno con Esa diva, che in Spagna ha ottenuto comunque un discreto successo commerciale (15.3M di streaming al momento in cui scrivo) e si è un po’ assestata come l’equivalente iberico di Pelle diamante, perfetta per i reel Instagram e i TikTok delle donne mature “che non devono chiedere mai” e che magari sognano di ballare in salotto con cappello, ventaglio e la gonna a ruota. Certo, l’esperimento del Benidorm Fest dovrà necessariamente essere supportato da risultati, dato che dopo quattro anni viaggia ancora sui fumi dell’insperato bronzo di Chanel. L’impressione è che gli spagnoli per primi non sappiano che pesci pigliare, e che se anche dovesse in qualche modo emergere una proposta con potenziale eurovisivo (come poteva essere V.I.P. di J Kbello quest’anno) gli ostacoli da superare per conquistare il favoloso e volubile pubblico di Benidorm siano ormai troppi e spesso, paradossalmente, non musicali.
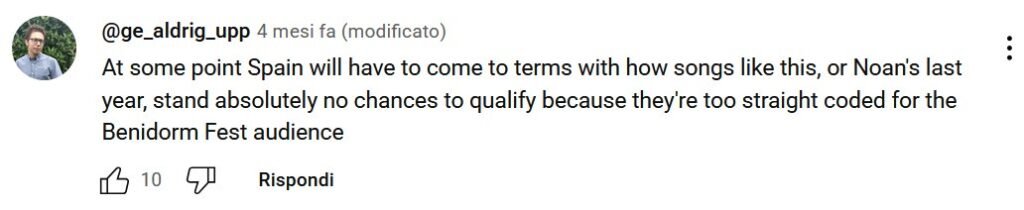
🇫🇮 🇲🇹 🇧🇪 A pensarci è davvero paradossale: il mondo non è mai stato così conservatore, almeno negli ultimi venticinque anni, eppure l’Eurovision – che proprio in questi anni ha scelto di farsi simbolo esplicito di multiculturalità, inclusione e accettazione in ogni forma – non solo non accenna a perdere popolarità ma ha appena segnato l’edizione complessivamente più vista dal 2021, con buona pace delle vedove inconsolabili del boicottaggio pro-Palestina e di chi (sottoscritto compreso) temeva che quest’anno si sarebbero finalmente raccolti i cocci della crisi di credibilità seminata a Malmö.
Eppure, a quanto pare, una delle lezioni di quest’anno è che l’empowerment femminile e una visione più emancipata, esplicita e “sfacciata” del corpo della donna restano ancora oggi difficili da vendere al grande pubblico eurovisivo: Finlandia e Malta, arrivate a Basilea con credenziali da top 10, si sono accomodate rispettivamente in undicesima e diciassettesima posizione. E se in qualche modo posso capire le ragioni del crollo della proposta maltese, con una performance eccessiva, sopra le righe e al limite del grottesco, forse nel tentativo di compensare la censura subita da EBU su serving Kant (“servire fessa”), che di fatto ha evirato il cuore del pezzo, è sicuramente uno smacco per la Finlandia che nel corso della settimana era cresciuta e arrivava a sabato sera contando di ottenere un piazzamento fra le primissime.
YLE ed Erika Vikman hanno fatto tutto bene: la performance di Ich komme è stata, a mio avviso, una vera e propria lezione su come mettere in scena – nel modo giusto – un’idea di emancipazione femminile che osa, provoca e rivendica il desiderio senza scadere nell’eccesso o nel ridicolo. Era evidente che la Finlandia giocasse su una doppia chiave di lettura e su un’autoironia consapevole, elementi totalmente assenti nel “servizio” kitsch e didascalico offerto da Malta. La differenza l’abbiamo vista chiaramente nel televoto (108 punti contro 8), anche se il sostegno a Erika è arrivato quasi esclusivamente da paesi scandinavi o comunque con una sensibilità più progressista.
Ma viene spontaneo chiedersi: cos’altro avrebbe dovuto fare per ottenere più consensi (a parte muovere il lato B come Chanel) una donna che vuole giocare con sensualità e provocazione sul palco dell’Eurovision? Anche leggendo le recensioni della stampa italiana, emerge chiaramente quanto certi pregiudizi siano duri a morire. Esiste ancora un’idea implicita e codificata su come una donna “possa” o “debba” presentarsi su un palco (ne stiamo leggendo anche in questi giorni, in relazione al tour di Elodie negli stadi) e anche l’Eurovision, nonostante tutta la sua patina di inclusività, non è del tutto immune da questi limiti. Per buona parte del pubblico, soprattutto in certi contesti, certe libertà sono ancora troppo scomode da vedere e soprattutto da votare.
Riflessione che vale anche per il Belgio, potenziale outsider uscito clamorosamente già in semifinale, e che senza i 12 punti della giuria di back-up di San Marino si sarebbe avvicinato pericolosamente all’ultimo posto. Red Sebastian, a mio avviso, ha pagato il prezzo di una proposta musicalmente non convenzionale e di una performance (a mio avviso pazzesca) in cui ha deciso di giocare apertamente con il proprio lato queer, senza edulcorarlo e senza tradirsi. Eppure, proprio questo coraggio si è scontrato con la realtà dei fatti: Red non è convenzionalmente avvenente e ha messo in discussione dei canoni estetici che – anche all’interno della comunità LGBTQIA+ – si reggono su pregiudizi e filtri radicati da ere geologiche. (Basta pensare, per esempio, a quanto accaduto a Sam Smith nel panorama pop internazionale.)
Che il brano fosse complesso e la performance vocale non perfetta (il falsetto non è per tutti, e ci sta) è fuori discussione. Ma resta il fatto che il pubblico generalista non lo ha capito – così come, a suo tempo, non aveva capito Telemòveis (Portogallo 2019). Ed è dura farsene una ragione, specie in un contesto che si vorrebbe progressista e originale just for the sake of it, ma dove i veri rischi spesso pagano il prezzo più alto.
GLI ACCREDITI NEGATI
Una cosa che non mi è mai piaciuta del giornalismo eurovisivo è la tendenza ad evitare certe discussioni perché si preferisce curare il proprio personale orticello, alla faccia della tanto decantata “grande famiglia” che si riunisce ogni anno in giro per l’Europa. Praticamente nessuno ha scritto in questi anni del progressivo attacco di EBU ai fan media e alla cosiddetta “stampa specializzata”, partita da una serie di restrizioni e culminata quest’anno con l’accredito negato ad alcuni dei suoi nomi più importanti: Gabe Milne, YouTube creator da quasi 50k iscritti; Daniel “vDanDesign” Stridh, fotografo e 3D designer tra le menti più brillanti della nuova generazione di fan; Szymon Stellmaszyk, giornalista ed eurofan polacco finito nell’occhio del ciclone per la sua domanda scomoda a Eden Golan in conferenza stampa; e altri ancora.
Non si tratta di casi isolati, ma di segnali inequivocabili di una volontà crescente di controllo sul racconto, che rischia di escludere proprio chi ha contribuito a rendere l’Eurovision un fenomeno globale e digitale. Concedere l’accredito ai primi fan media fu, ormai vent’anni fa, una scelta cruciale che trasformò il contest da evento televisivo di una sera in un buzz continuo lungo due settimane. Unita alla diffusione capillare dei social, fu la mossa che permise all’ESC di restare rilevante (a differenza di altri progetti EBU come Giochi senza frontiere) e di superare la crisi d’identità dei primi anni Duemila, coltivando una nuova generazione di “giornalisti” e content creator pronti a raccontarlo, seguirlo e amplificarlo a costo zero.
Le azioni della “nuova” dirigenza di EBU, dal COVID in poi, hanno smontato questo paradigma e ridotto sempre più il contenuto che i giornalisti potevano riportare. A Torino fu chiuso l’accesso della prima prova libera di ogni nazione, a Liverpool della seconda, sono state eliminate progressivamente tutte le conferenze stampa degli artisti, e già così l’apertura del Media Centre veniva ridotta da due settimane a una.
Contemporaneamente veniva annunciata la partnership con TikTok come Official Media Partner di EBU, e i contenuti ufficiali venivano dirottati in gran parte su quella piattaforma – quasi a sancire simbolicamente il passaggio dall’Eurovision “ruspante” e amatoriale degli anni Duemila a una nuova era fatta di numeri, reach e influencer. Neanche a dirlo, questo sviluppo ha fatto godere una parte significativa del fandom, italiani in primis: quelli che per dodici mesi l’anno pendono dalle labbra dei fan media, ma che al primo segnale di ufficialità non vedevano l’ora di vederli ridimensionati. I “sitarelli e blogghettini del cazzo” venivano finalmente rimessi “al loro posto”, impossibilitati a “farsi la vacanza” in sala stampa invece di pagare per un biglietto in arena come tutti gli altri. (Per chi scriveva certe cose tre anni fa, lo dissi allora e lo ripeto oggi: vale il più classico dei principi e cioè quello della volpe e dell’uva.)
Ad aumentare le mie perplessità era l’idea che queste continue restrizioni venissero giustificate come riduzione dei costi e soprattutto tutela del welfare e della privacy degli artisti che, “come in qualsiasi altro evento” hanno diritto di provare in pace e a porte chiuse. Dimostrazione invece, a mio avviso, che l’EBU si è reso conto di non poter controllare la parte più tossica e dannosa della nuova generazione di eurofan (in genere non quelli che scrivono dalla sala stampa, ma che commentano compulsivamente su Twitter dalle loro camerette) e ha deciso di ridurre il più possibile i contenuti messi a loro disposizione per evitare che l’eccessiva negatività si riflettesse negativamente sul racconto del contest.
Ricordate voi un artista che si sia mai lamentato del fatto che le prove libere fossero aperte alla stampa? Io no, in compenso mi ricordo di aver letto interviste di capidelegazione che raccontavano come spesso fosse proprio il feedback ricevuto dai fan dopo le prime prove pubbliche a permettere aggiustamenti decisivi in corso d’opera. Vero è che l’Eurovision è cambiato e l’introduzione delle stand-in rehearsal (delle prove aggiuntive fatte con figuranti prima dell’arrivo delle delegazioni, per fare immaginare la resa video delle performance e dare modo di suggerire eventuali cambiamenti) ha probabilmente reso impossibile situazioni in stile Russia 2008, quando l’intera performance di Dima Bilan venne stravolta – e a ragione – dalla prima prova al live. Resta il fatto che, entrando in scena la stampa dalle prime prove generali, il margine d’opera per eventuali cambiamenti è a quel punto ridottissimo. Riprendendo il discorso fatto su Louane: forse, in un Eurovision “aperto” fin dall’inizio, la Francia avrebbe potuto intercettare per tempo le criticità dello staging – e magari salvare una candidatura in cui aveva investito moltissimo, finita invece travolta da un singolo shot virale. E non ditemi che l’apertura avrebbe reso tutto “più tossico” perché quella gogna, a cose fatte, è arrivata lo stesso.
Perché proprio ora, nel momento di massima popolarità dell’Eurovision, EBU fa marcia indietro e si prefigge di ridurre la capienza del Media Centre da 1500 a 1000 posti parlando di “poco spazio” a disposizione? A Basilea gli accreditati stampa sono stati sistemati in un palazzetto del ghiaccio, con un’organizzazione logistica diversa da quella che ho sperimentato nei miei Eurovision precedenti: il palco delle conferenze, solitamente in una sala a parte, era piazzato al centro, mentre i sette tavoli riservati ai fan media (categoria M4) erano disposti dietro di esso, quasi a volerli “ostracizzare” dal resto della stampa.
Tanti hanno giustificato questa scelta dicendo che è conseguenza naturale del modo in cui parte della stampa eurovisiva ha trattato la partecipazione di Israele nel 2024: io penso più che altro che a non essere gradite siano state le prese di posizione contro EBU e Martin Österdahl, visti come non in grado di gestire una situazione che a Malmö ha raggiunto vette insostenibili e minacciato l’intero svolgimento del contest. Critiche motivate e fondate, che però non sono state digerite da chi gestisce un’organizzazione che oggi sembra più interessata a controllare la narrazione che a dialogare con chi ha contribuito a mantenere l’Eurovision rilevante.
Il proposito dell’EBU ha funzionato, perché quasi nessuno ha avuto il coraggio di metterne in discussione l’operato: nemmeno nei briefing quotidiani per la stampa, introdotti per la prima volta quest’anno, si è andati oltre le domande di rito. A rompere il silenzio è stato soltanto Tobbe Ek di Aftonbladet, giornalista “d’assalto” e veterano della stampa eurovisiva. Fin dal primo giorno Tobbe ha messo in discussione un punto controverso del nuovo Code of Conduct, firmato da tutti gli accreditati, in cui si vietava espressamente di dire, fare o scrivere qualcosa che potesse “danneggiare la reputazione dell’EBU”. Una clausola vaga, inquietante e difficilmente compatibile con la libertà di stampa, che lasciava intendere che ogni forma di dissenso, anche legittimo, potesse essere punita come una violazione disciplinare. La discussione è andata avanti per giorni, e si è conclusa con un impegno da parte dell’EBU a riscrivere le regole in vista del 2026.
Ora mi preme mettere nero su bianco che non sono un giornalista, lo dico per rispetto del “tesserino” e di chi ha svolto tutto un percorso accademico per definirsi tale. Le mie sette partecipazioni all’Eurovision (2015-2018 e 2023-2025) sono state svolte a titolo personale e soprattutto gratuito, senza mai aspettarmi che mi potesse tornare qualcosa in tasca dal mio coinvolgimento se non la soddisfazione di seguire da vicino un evento che amo e a cui voglio bene.
Credo però che la vera differenza non stia tra chi ha un tesserino e chi no, ma tra chi tratta l’Eurovision con rispetto e passione e chi invece si avvicina al contest con superficialità. Non è giusto sminuire il lavoro di chi copre il contest per dodici mesi l’anno – a titolo personale e solo sulla base della propria passione, perché pochissimi eletti vivono di questo “””lavoro””” – e lasciare campo libero solo ai media tradizionali. Peraltro, l’intero sistema è già di fatto aggirabile: molti fan media trovano comunque il modo di accreditarsi sotto l’ombrello di testate tradizionali (categoria M1/M2/M3), i cui accrediti vengono approvati dai rispettivi broadcaster e non dall’EBU, parecchi dei quali arrivano sul posto solo gli ultimi due/tre giorni ed esclusivamente per sparare a zero su tutto e scrivere castronerie su castronerie. Mi ci metto in mezzo anch’io, visto che appunto non sono un giornalista professionista, scrivo (saltuariamente) per fan media e sono sempre stato accreditato come M2 da quando esiste la regola attuale.
Ho affrontato Basilea 2025 con il pensiero che potesse essere il mio ultimo ESC on location, sia perché credo in questi anni di avere ottenuto un po’ tutto quello che desideravo da questa esperienza, sia perché come ho detto ogni anno diminuiscono le cose “esclusive” che la stampa in loco può raccontare, ma soprattutto perché so benissimo che domani potrebbe esserci un ulteriore giro di vite e le mie credenziali non basteranno più per farmi accreditare. (Già quest’anno sono finito in lista d’attesa e ho saputo che sarei stato effettivamente presente solo 15 giorni prima della mia partenza per la Svizzera.)
Mi metto però nei panni degli eurofan più giovani che si approcciano a questo mondo e sognano di raccontarlo come ho avuto la fortuna di poterlo fare in questi ultimi 10 anni. Alle condizioni attuali, è chiarissimo che un ragazzo che prova ad accreditarsi come ho fatto per la prima volta ai tempi di Vienna 2015 – a 21 anni, senza agganci e conoscenze di alcun tipo – non riuscirà mai ad avere le stesse possibilità che furono date all’epoca al sottoscritto e che mi permettono ancora dopo tutto questo tempo di essere qui a scrivere, raccontare e portare un contenuto il più possibile analitico e imparziale su tutto ciò che riguarda l’Eurovision.
Se l’Eurovision 2026 si terrà a Vienna, la scusa della capienza ridotta verrà meno, perché già nel 2015 ÖRF dimostrò di poter mettere insieme un Media Centre degno di tutti i crismi. Dobbiamo avere fiducia nei cambiamenti promessi da EBU? Non lo so, certo è che all’ESC ante-COVID non si tornerà più e per il racconto del contest per me si tratta di una grande perdita.
AUSTRIA 2026
E quindi l’Eurovision resta nella “vecchia Europa”, continuando a passare di mano in mano tra le nazioni dell’Europa occidentale. L’ultima edizione organizzata ad Est rimane quella di Kiev 2017, e ogni anno sembra più difficile che una nazione dell’Est possa vincere il concorso: in primis perché sono in minoranza numerica, in una situazione che si è diametralmente capovolta rispetto a 20 anni fa e che ogni anno vede nuovi ritiri e abbandoni momentanei (quest’anno è toccato alla Moldavia) per mancanza di interesse dei rispettivi broadcaster, problemi finanziari e incompatibilità dei valori di Eurovision con quelli propugnati dai rispettivi governi.
Quante nazioni ritroveremo in Austria? É difficile dirlo ora, certo tornare sopra “quota 40” sembra sempre più un’utopia e l’unico vero, realistico ritorno che si intravede in tempi brevi potrebbe essere quello di Monaco, con un approccio simile a quello visto in questi anni dal Lussemburgo. È possibile che si rivedano anche Moldavia, Romania o Macedonia del Nord, ma il rischio è che si tratti di partecipazioni estemporanee, dettate più dalla necessità di “fare numero” che da un vero progetto a medio-lungo termine per accrescere la popolarità e la rilevanza del brand Eurovision nel paese. In più, altrettante nazioni restano con un piede dentro e uno fuori (a partire dalla Repubblica Ceca) e potrebbero cogliere l’occasione del risultato controverso di Basilea 2025 per chiamarsi fuori in attesa di tempi più propizi: continuo a pensare che la perdita di credibilità di EBU e di tutto il contest sia più reale di quanto è passato quest’anno, e che le conseguenze potrebbero venire avvertite più avanti soprattutto se non si saprà rispondere in modo opportuno alle problematiche insorte quest’anno.
Continuo a ritenere fondamentale il ritorno delle giurie in semifinale: è l’unico modo per dare anche alle nazioni più piccole una reale possibilità di qualificazione senza dover ogni anno scendere a compromessi, piegandosi a tutti i costi alle logiche del televoto. Come dimostrano i casi di San Marino e Armenia quest’anno, può bastare essere sorteggiati nella semifinale “giusta” con tante nazioni “amiche” per staccare il biglietto per la finale, a prescindere dalla qualità artistica del brano. In questo scenario, molte delegazioni optano consapevolmente per brani costruiti ad hoc per attirare il televoto, nella speranza di evitare la bocciatura al primo taglio e garantirsi almeno un passaggio in finale (anche in fondo alla classifica). Questo, è sotto gli occhi di tutti, ha abbassato di molto il livello medio della manifestazione e in un certo senso l’ha riportata al trash di fine anni Duemila in quella che può già essere considerata una “seconda era del gimmick”.
Un altro aspetto che ha caratterizzato queste ultime edizioni e inevitabilmente ha reso il gioco “meno equo” è stato l’abbandono del sorteggio integrale delle posizioni d’uscita. Per ragioni televisive, si è passati dal sistema originario (in cui ogni nazione pescava una posizione esatta in scaletta) a un compromesso introdotto nel 2013, con l’assegnazione alla prima o seconda metà della semifinale o finale. Ma nemmeno questo è bastato e dal 2024, il metodo è stato ulteriormente modificato: metà dei partecipanti ottiene il famigerato Producer’s Choice, che consente agli autori dello show di collocarli ovunque – dall’#1 al #26 – mentre l’altra metà resta suddivisa, in modo bilanciato, tra prima e seconda metà. Una scelta che, pur comprensibile da un punto di vista scenico e televisivo, ha inevitabilmente aumentato le diseguaglianze e ridotto la trasparenza.
Ci sta che RAI stabilisca l’ordine di uscita delle canzoni in ogni serata del Festival di Sanremo, o che il produttore esecutivo di SVT stili la scaletta di uscita della finale del Melodifestivalen: sono prodotti realizzati internamente dai rispettivi broadcaster ed è giusto che ognuno tuteli i propri interessi e la migliore riuscita possibile dello show. Ma possiamo davvero dire che con il sistema attuale in vigore all’ESC ogni nazione venga valorizzata allo stesso modo, come aveva promesso il contest producer Christer Björkman alla vigilia di Malmö 2024? No, ovviamente no. Tanto più se la decisione è rimessa nelle mani di una persona la cui visione è tutto tranne che imparziale – e che, come abbiamo visto quest’anno con Svezia vs. Estonia, può favorire o penalizzare a piacimento questa o quella nazione nascondendosi dietro alla scusa della “resa televisiva”.
A prescindere dal fatto che fosse giustificata o meno (e se lo era, lo era solo sulla base della graduatoria dei bookmaker) quella in cui Christer Björkman ha scelto di collocarsi è una posizione estremamente delicata. Mettere nelle mani di una sola persona la responsabilità di decidere l’ordine di uscita delle nazioni in gara espone inevitabilmente a sospetti, se non a vere e proprie accuse, di favoritismi o penalizzazioni. E anche nel migliore dei casi – con tutta la buona fede del mondo – è una scelta che rischia di minare la credibilità stessa della competizione.
Conscio che non si può pensare di tornare al sorteggio a cieco completo, vera croce e delizia dell’ESC dei primi Duemila (ricordate quando l’Azerbaigian, favoritissimo nel 2010, si trovò a pescare il #1?) abbraccio la soluzione proposta su Twitter dal mio amico Ruben Trasatti (Telesette): tornare a fare sì che ogni nazione sorteggi il proprio ordine di uscita, ma lasciare la libertà ai produttori di spostare ogni performance avanti o indietro di tre posizioni al fine di garantire una buona alternanza tra generi e ritmi. Un compromesso a mio avviso intelligente, che tutelerebbe il ritmo televisivo dello show senza sacrificare completamente il senso di equità e imprevedibilità che dovrebbe caratterizzare una competizione musicale – preservando comunque il flow televisivo dello spettacolo e allo stesso tempo provando a garantire un trattamento più equo delle nazioni in gara, e non costantemente sbilanciato in favore dei “soliti noti”.

In quanto alla gara in sé, sono sempre più convinto che il pubblico eurovisivo si stia progressivamente allontanando dall’ESC dei prop imponenti e delle performance costruite a tavolino per abbracciare una visione più “sanremese”, legata meno all’aspetto visivo e più alla genuinità e all’autenticità (percepita) di un approccio minimalista e tradizionale.
A tratti si ha l’impressione che i creative director abbiano già inventato tutto ciò che c’era da inventare – e l’esempio più lampante è forse quello di Cipro quest’anno, che pur mettendo in scena una performance ambiziosa e complessa, non è riuscita a sollevare una canzone che non aveva mai convinto. In questo contesto, il minimalismo può diventare la nuova frontiera competitiva, un’arma efficace soprattutto quando è supportata da un’identità artistica forte. Uno sviluppo che all’Italia farebbe ovviamente bene, dato che è un po’ la cifra che caratterizza già di per sé Sanremo e abbiamo sempre portato all’Eurovision con grande profitto.
Non so se già l’anno prossimo, ma penso che nel giro di tre edizioni assisteremo alla vittoria di un act che si esibirà sul palco supportato esclusivamente da sé stesso e dalla sua voce, come Lena Meyer-Landrut nel 2010 o Salvador Sobral nel 2017. Detto questo, l’elemento che più di ogni altro continua a fare la differenza al televoto è la star quality dell’artista – la capacità di “bucare lo schermo” e conquistare il pubblico nel giro di pochi secondi – oppure l’esistenza di una narrativa forte, interna o esterna alla canzone o alla performance, che renda la proposta immediatamente riconoscibile e memorabile. E anche da questo punto di vista, va detto, l’Eurovision si sta avvicinando sempre più a Sanremo e non a tutte le altre selezioni nazionali che vi si ispirano più direttamente.
Si chiude così, dopo oltre dodicimila parole, il racconto di quello che per me è stato l’Eurovision Song Contest 2025. Nonostante tutto, continuo a pensare che valga la pena continuare raccontare questo contest con uno sguardo personale, appassionato e (quando serve) critico. Spero di poterlo fare il più regolarmente possibile – più di quanto è stato quest’anno – da queste pagine, magari in modo più leggero e ficcante. Se saremo ancora qui a parlare di ESC e di bella musica, storie e spunti, questa sarà già una vittoria per tutto il contest e per chi vuole il suo bene.
Dave out!

